INCIPIT DI LIBRI DELL'OTTOCENTO
HONORÉ DE BALZAC - Eugenia Grandet /1833)
IVAN ALEKSANDER GONCAROV - Oblomov (1859)
THOMAS HARDY - Via dalla pazza folla (1874)
FËDOR DOSTOEVSKIJ - I fratelli Karamazov (1879)
OSCAR WILDE - Il ritratto di Dorian Gray (1890)
INVITO ALLA LETTURA
In questa pagina leggeremo incipit di libri classici dell'800. Propongo questi incipit come invito alla lettura delle opere.
HONORÉ DE BALZAC - Eugenia Grandet (1833)*
In alcune città di provincia si trovano case la cui vista ispira una malinconia simile a quella dei chiostri più tetri, delle lande piú desolate, delle rovine piú tristi: in queste case forse si trovano riuniti e il silenzio del chiostro, e l’aridità delle lande, e le rovine. Vita e movimento vi sono cosí tranquilli che un forestiero le riterrebbe inabitate, se d’un tratto non incontrasse lo sguardo smorto e freddo di una persona immobile, la cui figura, mezzo monastica, sporge dal parapetto della finestra al rumore di un passo insolito. Tale malinconia esiste anche in una casa di Saumur, in cima alla via montagnosa che mena al castello per la parte alta della città. Questa curiosa strada, ora poco frequentata, calda in estate e fredda in inverno, oscura in alcuni punti, si fa notare per il selciato sonoro, sempre a posto e arido, per la sua angustia e la sua tortuosità, per la dolce pace delle case che appartengono alla città vecchia che domina i bastioni. Vi sorgono ancora solide abitazioni di tre secoli, quantunque in legno, e i loro diversi aspetti concorrono all’originalità di questa parte di Saumur che attira l’attenzione degli antiquari e degli artisti. È difficile passare davanti a queste case senza ammirare i loro panconi enormi i cui spigoli sono intagliati e che coronano con un bassorilievo nero il pianterreno della maggior parte di esse. Qui, tavole trasversali son coperte di ardesia e disegnano linee bluastre sulle mura deboli di una casa coperta da un tetto e colombaio, che gli anni hanno fatto inclinare nelle sue assi mezzo fradice per la pioggia e il sole.
Là, appaiono imposte di finestre vecchie e annerite, di cui a malapena si scorgono le delicate sculture e che sembrano troppo fragili per il vaso d’argilla oscura, d’onde si slanciano i garofani o le rose di una povera operaia.
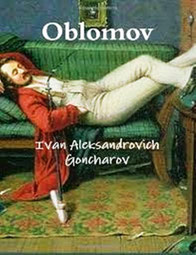
IVAN ALEKSANDROVICH GONCHAROV - Oblomov (1859)*
Una mattina Il'ja Il'iè Oblomov se ne stava a letto nell'appartamento che occupava in uno di quei casermoni di via Gorochovaja i cui inquilini sarebbero bastati a popolare un intero capoluogo di distretto.
Il'ja Il'iè era un uomo di circa trentadue-trentatré anni, di statura media, gradevole d'aspetto, con occhi grigio scuro; ma i tratti del volto rivelavano un'assoluta incapacità di determinazione e di concentrazione. Il pensiero volubile trascorreva senza guida sul suo viso, gli svolazzava negli occhi, si arenava fra le labbra semiaperte, si nascondeva fra i solchi della fronte, poi si dileguava di botto, e allora il volto restava rischiarato solo del vago lucore dell'indolenza. Dalla faccia, l'indolenza si propagava a tutto l'atteggiamento del corpo, addirittura alle pieghe della vestaglia.
Di quando in quando, un'espressione che si sarebbe detta di stanchezza o di noia gli offuscava lo sguardo; ma la stanchezza o la noia non potevano scacciare nemmeno per un momento la mitezza, che era la caratteristica essenziale e dominante non solo del volto, ma di tutta l'anima; e l'anima risplendeva aperta e chiara negli occhi, nel sorriso, in ogni movimento della testa o della mano. Un osservatore distaccato e superficiale, dopo una rapida occhiata a Oblomov, avrebbe potuto dire: «Deve essere un tipo semplice e di buona pasta!». Ma un osservatore più acuto e partecipe, che lo avesse osservato a lungo, si sarebbe forse allontanato sorridendo, immerso in gradevoli meditazioni.
Il colorito di Il'ja Il'iè non era né roseo, né olivastro, né decisamente pallido, ma smorto; o forse così sembrava perché Oblomov era troppo floscio, per l'età che aveva, a causa della mancanza di moto o di aria, o probabilmente di entrambi. Nell'insieme il suo corpo, a giudicare dal colore scialbo e troppo bianco del collo, delle mani piccole e paffute, delle spalle cascanti, appariva eccessivamente femmineo.
Anche i suoi movimenti, perfino quando era inquieto, venivano frenati dalla fiacchezza e dalla pigrizia, non priva, nel suo genere, di una certa grazia. Se la nube nera di una preoccupazione saliva dall'anima ad addensarsi sul viso, lo sguardo si offuscava, la fronte si corrugava, e dubbio, afflizione e timore iniziavano il loro girotondo; ma raramente questa inquietudine si coagulava in un'idea precisa, e ancor più raramente si trasformava in un proposito concreto. Tutta l'inquietudine si risolveva in un sospiro e si estingueva nell'apatia o nella sonnolenza.
Come armonizzava l'abito da casa con i tratti sereni del volto di Oblomov e con la mollezza del suo corpo! Indossava una vestaglia di stoffa persiana, una autentica gabbana all'orientale, senza nulla di europeo, senza nappe, senza velluto, senza vita, tanto ampia che Oblomov ci si poteva avvolgere dentro due volte. Le maniche, secondo l'immutabile moda asiatica, andavano allargandosi dalle dita alle spalle. Malgrado avesse perduto l'originale freschezza, e la prima, naturale lucentezza fosse stata soppiantata qua e là da un lustro d'altro genere, determinato dall'uso, la gabbana conservava pur sempre la vivacità dei colori orientali e la solidità del tessuto.

*THOMAS HARDY - Via dalla pazza folla (1874)*
Quando il fittavolo Oak sorrideva, gli angoli della bocca gli si slargavano fino a trovarsi a esigua distanza dagli orecchi; gli occhi gli si riducevano a due fessure; e apparivano
loro intorno certe grinze divergenti che si stendevano sulla sua fisionomia come i raggi di un rudimentale abbozzo di sole nascente.
Di nome si chiamava Gabriele, e nei giorni feriali era un giovanotto di giudizio, di movimenti sciolti, abiti decenti e generalmente buona condotta. La domenica era uomo di idee nebulose, piuttosto portato a differire le cose, e imbarazzato dai suoi abiti festivi e dal suo ombrello; in breve, uno che sentiva di occupare moralmente quel vasto spazio mediano di laodiceana neutralità che si frapponeva tra la popolazione della parrocchia partecipante alla Comunione e la sezione beoni - il che è quanto dire che in chiesa andava, ma sbadigliava segretamente quando la congregazione era arrivata al Credo niceno, e pensava a cosa ci sarebbe stato per cena, mentre era persuaso di attendere ad ascoltare la predica. O, per definire il suo carattere, quale appariva sulla bilancia della pubblica opinione quando i suoi amici e critici erano di cattivo umore, era considerato piuttosto come un cattivo soggetto; quando erano di buon umore, era piuttosto una brava persona; quando non erano né l'uno né l'altro, era un uomo il cui colorito morale era una specie di miscuglio di sale e pepe.
FËDOR DOSTOEVSKIJ - I fratelli Karamazov (1879)*
I • Fëdor Pavloviè Karamazov
Aleksej Fëdoroviè Karamazov era il terzo figlio di un proprietario terriero del nostro distretto, Fëdor Pavloviè Karamazov, assai
noto ai suoi tempi (e del resto ancor oggi ricordato fra noi) per la sua tragica e oscura fine, avvenuta esattamente tredici anni fa e della quale parlerò a tempo debito. Adesso, invece, di questo "proprietario terriero" (come lo si chiamava da noi, anche se in tutta la sua vita non aveva abitato quasi mai nella sua proprietà), dirò solo che era un tipo strano, di quelli che tuttavia si incontrano abbastanza spesso, il tipo di persona non soltanto abietta e depravata, ma anche balorda, di quei balordi, però, che sanno gestire egregiamente i propri affarucci e, a quanto pare, solo quelli. Fëdor Pavloviè, ad esempio, aveva cominciato quasi dal nulla; la sua proprietà era modestissima, correva di qua e di là per pranzare alla tavola altrui, si ingegnava a fare il parassita, eppure al momento del trapasso gli trovarono ben centomila rubli in contanti, anche se nel contempo aveva continuato ad essere per tutta la vita uno dei più dissennati scavezzacolli di tutto il nostro distretto. Lo ripeto ancora: qui non si tratta di stupidità - la maggior parte di questi scavezzacolli è abbastanza intelligente e scaltra - si tratta proprio di dissennatezza, e per giunta di un tipo particolare, nazionale.
OSCAR WILDE - Il ritratto di Dorian Gray (1890)*
Lo studio era pieno dell'odore intenso delle rose, e quando il venticello estivo passava tra gli alberi del giardino, penetrava dalla porta aperta il profumo greve del glicine o la fragranza più delicata del biancospino.
Dall'angolo del divano di cuscini persiani sul quale stava disteso, fumando, com'era sua abitudine, numerose sigarette, Lord Henry Wotton poteva appena intravedere lo splendore dei fiori di citiso, che hanno la dolcezza e il colore del miele. I rametti fragili sembravano quasi incapaci di sostenere il peso di tanta scintillante bellezza. Le ombre fantastiche degli uccelli in volo penetravano ogni tanto attraverso le lunghe tende di seta cruda, che, aperte davanti alla grande finestra, producevano quasi un temporaneo effetto giapponese e facevano pensare a quei pallidi pittori di Tokyo, con la faccia di giada, che, impiegando come strumento un'arte che è per forza di cose statica, cercano di darci il senso della velocità e del movimento. Il ronzio testardo delle api che si facevano strada attraverso l'erba lunga, non rasata, o giravano con insistenza monotona intorno alle punte dorate e impolverate del caprifoglio rampicante, pareva rendere il silenzio ancora più opprimente. Il rombo confuso di Londra sembrava l'accompagnamento di un organo lontano.
Nel centro della camera, posto su un cavalletto verticale, c'era il ritratto in piedi di un giovane di una straordinaria bellezza fisica; e davanti, a una certa distanza, era seduto l'artista stesso, Basil Hallward, la repentina scomparsa del quale, qualche anno fa, suscitò tanto scalpore quando avvenne e fece nascere parecchie strane congetture.
 CULTURA & SVAGO
CULTURA & SVAGO