INCIPIT DI LIBRI EDITI DAL 1936 AL 1949
Arthur Koestler - Buio a mezzogiorno (1940)
Albert Camus - Lo straniero (1942)
George Orwell - La fattoria degli animali (1945)
Elio Vittorini - Uomini e no (1945)
Cesare Pavese - La casa in collina (1948)
INVITO ALLA LETTURA
In questa pagina leggeremo incipit di libri classici dell'800 e del '900. Propongo questi incipit come invito alla lettura delle opere.
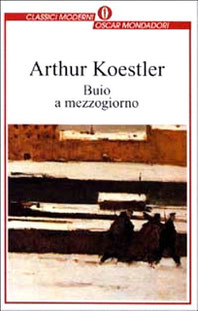
ARTHUR KOESTLER - Buio a mezzogiorno (1940)*
La porta della cella si chiuse con un colpo secco alle spalle di Rubasciov.
Egli restò appoggiato con le spalle alla porta per qualche secondo, e accese una sigaretta. Sul lettuccio alla sua destra c'erano due coperte pulite e il pagliericcio era stato rinnovato di fresco. La catinella alla sua sinistra non aveva tappo, ma il foro di scarico funzionava. Il bugliolo accanto era stato appena disinfettato e non puzzava. Le pareti su ambo i lati erano di solidi mattoni, il che avrebbe attutito il suono di qualsiasi colpo contro il muro, ma là dove il tubo del riscaldamento e quello di scarico lo attraversavano, era stata data una mano di calce e in quel punto risuonava sonoro; inoltre lo stesso tubo del riscaldamento sembrava un buon conduttore del suono. La finestra aveva inizio all'altezza dell'occhio, così che si poteva guardare nel cortile senza doversi sollevare sospendendosi alle sbarre dell'inferriata. In questo campo tutto era a posto.
Rubasciov sbadigliò, si tolse la giacchetta e, arrotolatala, la pose sul pagliericcio a mo' di guanciale. Poi guardò nel cortile. La neve aveva uno scintillìo giallastro alla doppia luce della luna e delle lampade elettriche. Intorno al cortile lungo i muri, era stato aperto nella neve un angusto passaggio per la passeggiata quotidiana. L'alba non era ancora sorta; le stelle brillavano ancora lucenti e gelide, nonostante le lampade. Sul bastione del muro esterno, che si levava proprio davanti alla cella di Rubasciov, un soldato col moschetto abbassato andava avanti e indietro; batteva gli scarponi ad ogni passo come se si fosse trovato a sfilare in parata. Ogni tanto la luce giallastra delle lampade lampeggiava sulla sua baionetta.
Rubasciov si tolse le scarpe, sempre davanti alla finestra. Finì la sigaretta, ne buttò il mozzicone per terra ai piedi del suo lettuccio, e rimase seduto sul pagliericcio per alcuni minuti. Quindi tornò ancora alla finestra. Il cortile era immerso nella pace più profonda; la sentinella proprio in quell'istante si voltava per ritornare sui suoi passi; sopra la torretta della mitragliatrice il prigioniero vide una striscia della Via Lattea.
Rubasciov si coricò sul giaciglio, avvolgendosi nella prima coperta.
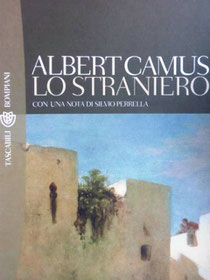
ALBERT CAMUS - Lo straniero (1942)*
Oggi la mamma è morta. O forse ieri, non so. Ho ricevuto un telegramma dall'ospizio: "Madre deceduta. Funerali domani. Distinti saluti". Questo non dice nulla: è stato forse ieri.
L'ospizio dei vecchi è a Marengo, a ottanta chilometri da Algeri. Prenderò l'autobus delle due e arriverò ancora nel pomeriggio. Così potrò vegliarla e essere di ritorno domani sera. Ho chiesto due giorni di libertà al principale e con una scusa simile non poteva dirmi di no. Ma non aveva l'aria contenta. Gli ho persino detto: "Non è colpa mia". Lui non mi ha risposto. Allora ho pensato che non avrei dovuto dirglielo. Insomma, non avevo da scusarmi di nulla. Stava a lui, piuttosto, di farmi le condoglianze. Ma certo lo farà dopodomani, quando mi vedrà in lutto. Per adesso è un po' come se la mamma non fosse morta; dopo il funerale, invece, sarà una faccenda esaurita e tutto avrà preso un andamento più ufficiale.
Ho preso l'autobus delle due: faceva molto caldo. Prima ho mangiato in trattoria, da Celeste, come al solito. Avevano tutti molta compassione per me e Celeste mi ha detto: "Di mamme ce n'è una sola". Quando ho fatto per andarmene, mi hanno accompagnato alla porta. Ero un po' intontito perché ero anche andato su da Emanuele a farmi prestare una cravatta nera e una benda per il braccio. Lui ha perso suo zio qualche mese fa.
Ho dovuto correre per non perdere l'autobus. La gran fretta, la corsa, certo è per questo, oltre alle scosse, all'odor di benzina, al riverbero della strada e del cielo, che presto mi sono assopito. Ho dormito quasi tutto il percorso. E quando mi sono svegliato ero addossato a un militare che mi ha sorriso e mi ha chiesto se venivo di lontano. Ho detto "Sì" per non dover più parlare.
L'ospizio è a due chilometri dal villaggio: ho fatto la strada a piedi. Volevo vedere subito la mamma, ma il portinaio mi ha detto che dovevo prima andare dal direttore. Siccome era occupato, ho atteso per un po' e intanto il portinaio non smetteva di parlare. Poi ho visto il direttore: mi ha ricevuto nel suo ufficio.

GEORGE ORWELL - La fattoria degli animali (Animal Farm, 1945)*
Capitolo I
Il signor Jones, della Fattoria Padronale, serrò a chiave il pollaio per la notte, ma, ubriaco com'era, scordò di chiudere le finestrelle. Nel cerchio di luce della sua lanterna che danzava da una parte all'altra attraversò barcollando il cortile, diede un calcio alla porta retrostante la casa, da un bariletto nel retrocucina spillò un ultimo bicchiere di birra, poi si avviò su, verso il letto, dove la signora Jones già stava russando.
Non appena la luce nella stanza da letto si spense, tutta la fattoria fu un brusio, un'agitazione, uno sbatter d'ali. Durante il giorno era corsa voce che il Vecchio Maggiore, il verro Biancocostato premiato a tutte le esposizioni, aveva fatto la notte precedente un sogno strano che desiderava riferire agli altri animali. Era stato convenuto che si sarebbero tutti riuniti nel grande granaio, non appena il signor Jones se ne fosse andato sicuramente a dormire. Il Vecchio Maggiore (così era chiamato, benché fosse stato esposto con il nome di Orgoglio di Willingdon) godeva di così alta considerazione nella fattoria che ognuno era pronto a perdere un'ora di sonno per sentire quello che egli aveva da dire.
A un'estremità dell'ampio granaio, su una specie di piattaforma rialzata, il Vecchio Maggiore già stava affondando sul suo letto di paglia, sotto
una lanterna appesa a una trave. Aveva dodici anni e cominciava a divenire corpulento, ma era pur sempre un
maiale dall'aspetto maestoso, spirante saggezza e benevolenza, benché mai fosse stato castrato. In breve cominciarono a giungere gli altri animali e ognuno si accomodava a seconda della propria natura. Vennero primi i tre cani, Lilla,
Jessie e Morsetto, poi i porci che si adagiarono sulla paglia immediatamente davanti alla piattaforma, le
galline si appollaiarono sul davanzale delle finestre, i piccioni svolazzarono sulle travi, le pecore e le mucche si accovacciarono dietro ai maiali e cominciarono a ruminare. I due cavalli da tiro, Gondrano e Berta, arrivarono assieme, camminando
lenti e appoggiando cauti i loro ampi zoccoli pelosi per tema che qualche piccolo animale potesse trovarsi
nascosto nella paglia. Berta era una grossa, materna cavalla di mezza età che, dopo il quarto parto, non aveva più riacquistato la sua linea.
ELIO VITTORINI - Uomini e no (1945)*
L'inverno del '44 è stato a Milano il più mite che si sia avuto da un quarto di secolo; nebbia quasi mai, neve mai, pioggia non più da novembre, e non una nuvola per mesi; tutto il giorno il sole. Spuntava il giorno e spuntava il sole; cadeva il giorno e se ne andava il sole. Il libraio ambulante di Porta Venezia diceva: «Questo è l'inverno più mite che abbiamo avuto da un quarto di secolo. È dal 1908 che non avevamo un inverno così mite.»
«Dal 1908?» diceva l'uomo del posteggio biciclette. «Allora non è un quarto di secolo. Sono trentasei anni.»
«Bene,» il libraio diceva. «Questo è l'inverno più mite che abbiamo avuto da trentasei anni. Dal 1908.»
Egli aveva perduto il suo banco nei giorni della distruzione di agosto; aveva lasciato la città; e non è ritornato a Porta Venezia che al principio di dicembre per poter vedere questo che vedeva: il più mite inverno di Milano dopo il 1908.
Splendeva il sole sulle macerie del '43; splendeva, ai Giardini, sugli alberi ignudi e sulle cancellate; ed era una mattina nell'inverno, era gennaio. Un uomo si fermò davanti al banco dei libri; portava una bicicletta per mano.
«Buongiorno,» il libraio gli disse.
«Buongiorno.»
«Che inverno, eh!»
«Che inverno è?»
«È l'inverno più mite che abbiamo avuto da un quarto di secolo.»
Si avvicinò l'uomo del posteggio.
«Da un quarto di secolo?» disse. «O dal 1908?»
«Dal 1908,» disse il libraio. «Dal 1908.»
CESARE PAVESE - La casa in collina (1948)
Già in altri tempi si diceva la collina come avremmo detto il mare o la boscaglia. Ci tornavo la sera, dalla città che si oscurava, e per me non era un luogo tra gli altri, ma un aspetto delle cose, un modo di vivere. Per esempio, non vedevo differenza tra quelle colline e queste antiche dove giocai bambino e adesso vivo: sempre un terreno accidentato e serpeggiante, coltivato e selvatico, sempre strade, cascine e burroni. Ci salivo la sera come se anch'io fuggissi il soprassalto notturno degli allarmi, e le strade formicolavano di gente, povera gente che sfollava a dormire magari nei prati, portandosi il materasso sulla bicicletta o sulle spalle, vociando e discutendo, indocile, credula e divertita.
Si prendeva la salita, e ciascuno parlava della città condannata, della notte e dei terrori imminenti. Io che vivevo da tempo lassù, li vedevo a poco a poco svoltare e diradarsi, e veniva il momento che salivo ormai solo, tra le siepi e il muretto. Allora camminavo tendendo l'orecchio, levando gli occhi agli alberi familiari, fiutando le cose e la terra. Non avevo tristezze, sapevo che nella notte la città poteva andare tutta in fiamme e la gente morire. I burroni, le ville e i sentieri si sarebbero svegliati al attino calmi e uguali. Dalla finestra sul frutteto avrei ancora veduto il mattino. Avrei dormito dentro un letto, questo sì.
 CULTURA & SVAGO
CULTURA & SVAGO