Incipit nuovi libri (1990-1993)
In questa pagina vengono proposti gli incipit di libri editi recentemente, best sellers e romanzi scelti tra quelli maggiormente venduti.
DACIA MARAINI - La lunga vita di Marianna Ucrìa (1990)
JOSTEIN GAARDER - Il mondo di Sofia (1991)
JOHN GRISHAM - Il socio (1991)
SUSAN SONTAG - L'amante del vulcano - 1992
SVEVA CASATI MODIGNANI - Il cigno nero (1992)
JAMES REDFIELD - La profezia di Celestino (1993)
ALESSANDRO BARICCO - Oceano mare (1993)
DACIA MARAINI - La lunga vita di Marianna Ucrìa (1990)

Un padre e una figlia eccoli lì: lui biondo, bello, sorridente, lei goffa, lentigginosa, spaventata. Lui elegante e trasandato, con le calze ciondolanti, la parrucca infilata di traverso, lei
chiusa dentro un corsetto amaranto che mette in risalto la carnagione cerea.
La bambina segue nello specchio il padre che, chino, si aggiusta le calze bianche sui polpacci. La bocca è in movimento ma il suono delle parole non la raggiunge, si perde prima di arrivare
alle sue orecchie quasi che la distanza visibile che li separa fosse solo un inciampo dell'occhio. Sembrano vicini ma sono lontani mille miglia.
La bambina spia le labbra del padre che ora si muovono più in fretta. Sa cosa le sta dicendo anche se non lo sente: che si sbrighi a salutare la signora madre, che scenda in cortile con
lui, che monti di corsa in carrozza perché, come al solito sono in ritardo.
Intanto Raffaele Cuffa che quando è alla "casena" cammina come una volpe a passi leggeri e cauti, ha raggiunto il duca Signoretto e gli porge una larga cesta di vimine intrecciato su cui
spicca una croce bianca.
Il duca apre il coperchio con un leggero movimento del polso che la figlia riconosce come uno dei suoi gesti più consueti: è il moto stizzoso con cui getta da una parte le cose
che lo annoiano. Quella mano indolente e sensuale si caccia fra le stoffe ben stirate, rabbrividisce al contatto col gelido crocifisso d'argento, dà una strizzata al sacchetto pieno di
monete e poi sguscia fuori rapida. Ad un cenno, Raffaele Cuffa si affretta a richiudere la cesta. Ora si tratta solo di fare correre i cavalli fino a Palermo.
Marianna intanto si è precipitata nella camera da letto dei genitori dove trova la madre riversa f ra le lenzuola, la camicia gonfia di pizzi che le scivola su una spalla, le dita della
mano chiuse attorno alla tabacchiera di smalto.
La bambina si ferma un attimo sopraffatta dall'odore del trinciato al miele che si mescola agli altri effluvi che accompagnano il risveglio materno: olio di rose, sudore rappreso, orina secca,
pasticche al profumo di giaggiolo.
La madre stringe a sé la figlia con un gesto di pigra tenerezza.
Marianna vede le labbra che si muovono ma non vuole fare lo sforzo di indovinarne le parole. Sa che le sta dicendo di non attraversare la strada da sola perché sorda com'è potrebbe trovarsi
stritolata sotto una carrozza che non ha sentito arrivare. E poi i cani, che siano grandi o piccoli, che stia alla larga dai cani. Le loro code, lo sa bene, si allungano fino ad avvolgersi
intorno alla vita delle persone come fanno le chimere e poi zac, ti infilzano con quella punta biforcuta che sei morta e neanche te ne accorgi...
JOSTEIN GAARDER - IL MONDO DI SOFIA (1991)
IL GIARDINO DELL'EDEN.
...insomma, qualcosa doveva essere stato creato una prima volta dal nulla...
Sofia Amundsen stava tornando da scuola. Aveva percorso il primo tratto di strada insieme a Jorunn e avevano parlato di robot. Secondo Jorunn, il cervello degli esseri umani era paragonabile a un
computer assai sofisticato: Sofia però non era molto d'accordo. Un uomo doveva essere qualcosa di più di una semplice macchina.
Si erano separate davanti al grande centro commerciale. Sofia abitava ai margini di un'ampia zona residenziale formata da villette e la strada che doveva fare per andare a scuola era due volte
quella di Jorunn. La sua casa pareva trovarsi ai confini del mondo, perché dietro il giardino non ce n'erano altre. In quel punto cominciava un fitto bosco.
Sofia stava girando in via Kleverveien. Nell'ultimo tratto la strada svoltava bruscamente e quella curva era nota come la «Curva del Capitano». Solo il sabato e la domenica era possibile
incontrare qualcuno da quelle parti.
Era l'inizio di maggio. In alcuni giardini i narcisi formavano corone di fiori ai piedi degli alberi da frutto. Le betulle cominciavano a coprirsi di foglioline verdi. Non era strano che tutto
cominciasse a sbocciare e a crescere proprio in quel periodo dell'anno, pensò. Perché chili e chili di materia verde spuntavano dalla terra inanimata solo quando l'aria diventava più calda e si
scioglievano le ultime tracce di neve?
Sofia sbirciò nella cassetta delle lettere mentre apriva il cancelletto del giardino. Di solito c'erano una grande quantità di volantini pubblicitari e alcune grosse buste per sua madre. Sofia
impilava sempre tutto per bene sul tavolo della cucina prima di salire in camera a fare i compiti.
Talvolta c'era qualche lettera della banca, indirizzata a suo padre. Ma il papà di Sofia era diverso dagli altri: essendo capitano di una grande petroliera, stava lontano per gran parte
dell'anno.
Quando rimaneva a casa per alcune settimane, girava sempre in ciabatte e colmava di attenzioni Sofia e la mamma. Tuttavia, se era in viaggio, il ricordo di lui spesso si affievoliva.
Quel giorno c'era soltanto una lettera minuscola, ed era per Sofia.
«Sofia Amundsen, Kleverveien 3», c'era scritto sulla busta.
Tutto qui. Nessun mittente. Mancava anche il francobollo.
Subito dopo aver richiuso il cancelletto, aprì la lettera. Vi trovò solo un foglietto non più grande della busta. Sul pezzetto di carta c'era scritto: «Chi sei tu?»
Nient'altro. Né la firma né i saluti, soltanto quelle tre parole scritte a mano e seguite da un grosso punto interrogativo. Sì, la lettera era proprio indirizzata a lei. Ma chi l'aveva infilata
nella cassetta?
Sofia si affrettò a entrare nella casa rossa. Come al solito il gatto Sherekan sbucò dai cespugli, saltò sul pianerottolo e riuscì a sgusciare dentro prima che chiudesse la porta.
«Micio, micio, micio!»
Quando la mamma di Sofia era arrabbiata per qualche motivo, diceva che la loro non era una casa, bensì un serraglio. A dire il vero, Sofia era molto soddisfatta della sua casa. Per prima cosa le
avevano comprato una boccia con i pesciolini Oro, Cappuccetto Rosso e Fuliggîne. Poi era stata la volta di Briciola e Briciolo, due cocorite, di Govinda, la tartaruga, e infine di Sherekan, un
gatto tigrato. Le avevano regalato tutti questi animali a mo' di risarcimento, perché sua madre tornava a casa tardi dal lavoro e suo padre era quasi sempre in giro per il mondo.
Sofia si sfilò lo zainetto e mise un po' di cibo per gatti in una ciotola che diede a Sherekan. Poi si sedette su uno sgabello della cucina con la lettera misteriosa in mano.
«Chi sei tu?»
JOHN GRISHAM - Il socio (1991)
Il socio anziano studiò il curriculum per la centesima volta e per la centesima volta non trovò niente da eccepire riguardo a Mitchell Y. McDeere, almeno sulla carta. Aveva intelligenza,
ambizione, bell'aspetto. Ed era affamato: doveva esserlo per forza, con quei precedenti. Era sposato, come d'obbligo. Lo studio legale non aveva mai assunto un avvocato scapolo e disapprovava
energicamente il divorzio, il correre dietro alle donne e l'abitudine all'alcol. Il contratto prevedeva un controllo antidroga. Era specializzato in diritto amministrativo, aveva superato l'esame
di abilitazione al primo tentativo e aspirava a diventare avvocato fiscalista, il che era ovviamente un requisito importante per uno studio legale specializzato in questioni fiscali. Era bianco e
lo studio non aveva mai assunto un negro: riusciva a mantenersi molto riservato ed esclusivo perché non sollecitava mai le richieste di impiego. Altri studi lo facevano e assumevano i negri.
Questo, invece, acquisiva soci e restava tutto bianco. Inoltre, la sede era a Memphis, figurarsi, e i negri più qualificati volevano andare a lavorare a New York, Washington o Chicago. McDeere
era maschio, e nello studio non c'erano donne. Quell'errore era stato commesso una sola volta a metà degli anni Cinquanta quando avevano preso come socio il primo in graduatoria dei laureati di
Harvard, che era appunto una donna e una vera maga in fatto di problemi fiscali. Aveva resistito per quattro anni turbolenti ed era morta in un incidente d'auto.
Sulla carta McDeere sembrava promettente. Rappresentava per loro la migliore opportunità. Anzi, per quell'anno non c'erano altri possibili candidati. L'elenco era brevissimo: o McDeere o
nessuno.
Il socio dirigente, Royce McKnight, studiava un dossier intestato "Mi-tchell Y. McDeere - Harvard". Era un fascicolo spesso un paio di centimetri, con rapporti a caratteri minutissimi e poche
fotografie, ed era stato preparato da certi ex agenti della CIA che lavoravano in un'agenzia di informazioni privata con sede a Bethesda. Erano clienti dello studio e ogni anno effettuavano le
indagini senza presentare il conto. Era un lavoro facilissimo, dicevano, controllare gli ignari studenti di legge. Avevano scoperto, per esempio, che McDeere avrebbe preferito lasciare il
nordest, che aveva tre offerte di lavoro, due a New York e una a Chicago, e che la più alta era di 76.000 dollari, la più bassa 68.000. Era piuttosto richiesto. Durante il secondo anno di
università gli era stata data la possibilità di barare all'esa-me sui titoli pubblici. Aveva rifiutato e aveva preso il voto più alto del suo corso. Due mesi prima gli avevano offerto la cocaina
in una festa di studenti. Aveva detto di no e quando tutti avevano cominciato a sniffare se n'era andato. Ogni tanto beveva una birra, ma bere costava e lui non aveva soldi. Aveva un debito di
circa 23.000 dollari con il fondo prestiti riservato agli studenti. Era affamato.
Royce McKnight sfogliò il dossier e sorrise. McDeere era l'uomo per loro.
Susan Sontag - L'amante del vulcano - 1992
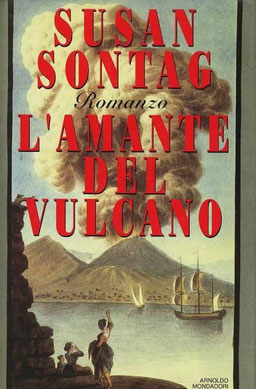
PROLOGO
All'entrata d'un mercato delle pulci. Gratuito. Ingresso libero. Folla sciolta. Volpina, festosa. Perché entrare? Cosa t'aspetti di vedere? Vedo.
Controllo quel che c'è al mondo. Quel che resta. Quel che è scartato. Quel che non sta più a cuore. Quel che doveva essere sacrificato. Quel che qualcuno ha pensato potesse interessare a qualcun altro. Ma è ciarpame. Se è lì, qui, è già stato passato al setaccio. Ma potrebbe esserci qualcosa di valore, lì. Non di valore, non proprio. Ma qualcosa che io potrei volere.
Volere mettere in salvo. Qualcosa che parli a me. Ai miei desideri. Parli a, parli di. Ah...
Perché entrare? Hai tanto tempo libero? Guarderai. Vagherai. Perderai le tracce del tempo. Pensi d'avere tempo a sufficienza. Ci vuole sempre più tempo di quanto pensi. Poi sarai in ritardo. Te la prenderai con te stessa.
Vorrai restare. Sarai tentata. Sarai respinta. Gli oggetti sono insudiciati.
Alcuni sono rotti. Mal rabberciati o per niente. Mi racconteranno passioni, fantasie che non ho bisogno di conoscere. Bisogno. Ah, no. Non ho bisogno di niente di ciò. Qualcuno l'accarezzerò con lo sguardo. Qualcuno devo prenderlo, coccolarlo. Mentre sono sorvegliata, abilmente, dai loro venditori. Non sono una ladra. Probabilmente, non sono una compratrice.
Perché entrare? Solo per giocare. Un gioco di riconoscimenti. Sapere cosa c'era e quanto valeva, quanto dovrebbe valere, quanto varrà. Ma forse non per fare un'offerta, mercanteggiare, non per acquistare. Solo per guardare. Solo per lasciarmi andare. Mi sento leggera. Non ho niente in mente.
Perché entrare? Ci sono tanti luoghi come questo. Un campo, una piazza, una galleria, una caserma, un parcheggio, un molo. Potrebbe essere altrove, ma si dà il caso che sia qui. Sarà pieno di ovunque. Ma è qui che io entrerò. Con i miei jeans, la camicetta di seta e le scarpe da tennis: Manhattan, primavera del 1992.
Sveva Casati Modignani - Il cigno nero (1992)
L'AVVOCATO Ovide Décroly, esperto in diritto societàrio internazionale e titolare di uno dei più importanti studi legali di Ginevra con venti soci e trenta associati, guardò dritto negli occhi
l'uomo che gli sedeva di fronte: «Dottor Montalto, è davvero consapevole di quello che sta per fare?» chiese lentamente.
Il legale ginevrino aveva un fisico asciutto e uno sguardo severo e penetrante. Il suo aspetto incuteva soggezione agli avversari e infondeva sicurezza ai suoi clienti.
Dècroly conosceva Emiliano Montalto dal 1960, quando l'editore, trentenne, aveva sposato in seconde nozze l'aristocratica inglese Mary June Scott-Davis. Da allora aveva sempre assistito Emiliano
e la famiglia Montalto.
Della grande casa editrice conosceva ogni particolare.
Apprezzava l'intelligenza e la raffinata cultura di Emiliano e deprecava l'indolenza del suo carattere che consentiva al fratello e alle sorelle minori ogni sorta di prevaricazione.
Emiliano lasciava fare non per debolezza, ma per evitare incresciose liti famigliari che detestava.
Dècroly era fermamente persuaso che senza i suoi buoni consigli Emiliano, da tempo, sarebbe stato messo fuori causa dai fratelli. Lo aveva salvato più di una volta dalla voracità e dalla
stupidità dei parenti. Il progetto che Emiliano gli aveva appena esposto avrebbe procurato all'editore un danno irreparabile.
L'avvocato ginevrino, di origine belga, aveva avuto un nonno psichiatra, di cui portava il nome, fondatore di un importante scuola per il recupero dei bambini disadattati.
Dal nonno famoso, citato in tutti i testi di psichiatria Ovide aveva ereditato spiccate attitudini di psicologo e una particolare sensibilità che, nell'esercizio della sua professione, gli erano
state molto utili. Mentre fissava gli occhi di quel gagliardo e giovanile cinquantenne, si rendeva conto che il suo cliente-amico era sul punto di abbandonare la lotta.
«Dottor Montalto, è davvero sicuro di quello che sta per fare?»
ripeté l'avvocato.
Emiliano sorrise.
«É la seconda volta nella mia vita in cui mi sento veramente sicuro di qualcosa», rispose l'editore con grande tranquillità.
La prima volta, era accaduto il giorno in cui aveva conosciuto Arlette e aveva deciso che sarebbe stata la donna della sua vita fino alla fine dei suoi giorni.
I due uomini sedevano a una grande scrivania diplomatica Napoleone III in Satinwood, arricchita da bronzi cesellati in oro zecchino. Accanto, sul ripiano della libreria, campeggiava un severo
busto in marmo del filosofo Seneca.
Villa Ester, residenza estiva dei Montalto alla confluenza del lago di Como con il lago di Lecco, era assediata dal caldo di luglio. L'afa premeva contro i vetri piombati dell'antico edificio e
creava un sottile strato di nebbia lattescente e oppressiva sulla superficie immobile del lago.
JAMES REDFIELD - La profezia di Celestino (1993)
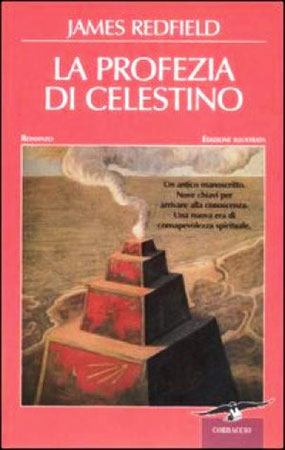
UNA MASSA CRITICA
Mi fermai davanti al ristorante e parcheggiai, appoggiandomi un attimo al sedile per pensare. Charlene mi aspettava già dentro, voleva parlarmi. Ma perché? Non la sentivo da sei anni: chissà per
quale motivo si era fatta viva proprio una settimana dopo che mi ero ritirato a vita solitaria nei boschi. Uscii dal furgone e mi avviai verso il ristorante. Alle mie spalle l'orizzonte
inghiottiva gli ultimi bagliori del tramonto e lame di luce color rame attraversavano il parcheggio bagnato. Soltanto un'ora prima un breve temporale aveva inzuppato ogni cosa, rinfrescando la
serata estiva che la luce morente del crepuscolo rendeva quasi irreale. In cielo intanto era comparsa la luna.
Mentre camminavo la mia mente era affollata da vecchie immagini di Charlene. Era ancora bella e intensa? In che modo il tempo l'aveva cambiata? E cosa avrei dovuto pensare di quel manoscritto che
mi aveva menzionato - un antico documento ritrovato in Sudamerica e di cui non vedeva l'ora di parlarmi?
« Devo aspettare due ore tra un volo e l'altro », mi aveva detto al telefono. «Possiamo vederci a cena? Il contenuto di questo manoscritto ti piacerà sicuramente - è proprio il genere di mistero
che ti appassiona. »
Il mio genere di mistero? Che cosa aveva voluto dire?
II ristorante era affollato, e alcune coppie stavano aspettando che si liberassero dei tavoli. La direttrice di sala mi disse che Charlene si era già accomodata e mi indirizzò verso una terrazza
che sovrastava la sala da pranzo principale.
Salii alcuni gradini e mi accorsi che intorno a uno dei tavoli si era radunata una piccola folla. C'erano anche due poliziotti che a un tratto si girarono e scesero di corsa i gradini,
oltrepassandomi. Appena l'assembramento di gente si disperse riuscii a vedere la persona che sembrava essere stata al centro dell'attenzione - una donna ancora seduta al tavolo... Charlene!
ALESSANDRO BARICCO - Oceano mare (1993)
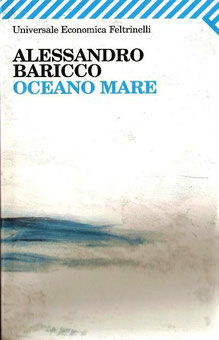
Sabbia a perdita d’occhio, tra le ultime colline e il mare - il mare - nell’aria fredda di un pomeriggio quasi passato, e benedetto dal vento che sempre soffia da nord.
La spiaggia. E il mare.
Potrebbe essere la perfezione - immagine per occhi divini - mondo che accade e basta, il muto esistere di acqua e terra, opera finita ed esatta, verità - verità - ma ancora una volta è il
salvifico granello dell’uomo che inceppa il meccanismo di quel paradiso, un’inezia che basta da sola a sospendere tutto il grande apparato di inesorabile verità, una cosa da nulla, ma piantata
nella sabbia, impercettibile strappo nella superficie di quella santa icona, minuscola eccezione posatasi sulla perfezione della spiaggia sterminata. A vederlo da lontano non sarebbe che un punto
nero: nel nulla, il niente di un uomo e di un cavalletto da pittore.
Il cavalletto è ancorato con corde sottili a quattro sassi posati nella sabbia. Oscilla impercettibilmente al vento che sempre soffia da nord. L’uomo porta alti stivali e una grande giacca da
pescatore. Sta in piedi, di fronte al mare, rigirando tra le dita un pennello sottile. Sul cavalletto, una tela.
 CULTURA & SVAGO
CULTURA & SVAGO